|
Torre maggiore.
Sito n.: 12 - TORRE OROLOGIO (P.ZZA CAVOUR)
Il locus Tillizzo, di origine longobarda, fu assegnato al conte
Amico da Roberto il Guiscardo, che nella prima metà dell'XI
secolo aveva conquistato il Mezzogiorno d'Italia fondandovi
un proprio regno. Già dalla metà dell'XI secolo il locus
diventa un castrum e un centro autonomo, separato,
indipendente e più importante di Giovinazzo, Ruvo, Bitonto e
Molfetta.
La costruzione del castello e della cinta muraria fu iniziata
dallo stesso conte Amico, sulla fine degli anni settanta del
secolo, e proseguita dal figlio Goffredo. Da una charta del
novembre 1237 si rileva che fu Federico II ad ordinare il
consolidamento delle strutture di difesa davanti al castello,
affidandole al suo fedele ex logoteta del regno Andrea da
Bari, in quel tempo signore di Terlizzi. Sono noti inoltre i
nomi delle maestranze che vi presero parte, come mastro
Peregrino Di Ursone, mastro Deolaudamo di Romualdo,
mastro Egidio di mastro Effrem e alcune maestranze locali.
Tra il 1333 e il 1350 il Regno di Napoli dovette affrontare
alcuni tragici avvenimenti a seguito dell'assassinio di
Andrea, fratello del re Luigi d'Ungheria e marito di Giovanna
I d'Angiò. Nel 1349 il re d'Ungheria volle vendicarsi di coloro
che avevano tramato alle spalle del fratello, tra cui il conte
di Terlizzi, Gastone di Denicy. Dal cosentino si mosse così
un esercito di mercenari e poveri allo sbando, sotto le
insegne di Roberto Sanseverino, conte di Corigliano e fedele
servitore della regina Giovanna, titolare del trono di Napoli.
Dopo aver fatto scempio di Gravina e di Ruvo l'esercito si
diresse verso Terlizzi e l'assediò, ma fu costretto a ricorrere
al sistema della corruzione e del tradimento per aver
ragione del forte sistema difensivo e per conquistare la città.
Nel novembre del 1462 il castello svolge il ruolo di felice
dimora per Ferrante I d'Aragona. In epoca moderna solo la
casata Grimaldi per un certo periodo di tempo si è servita
del castello per propria abitazione. Nel 1524 Carlo V, re di
Spagna, stipulò un trattato di alleanza con il signore di
Monaco Agostino Grimaldi e nel 1532 strappò al principe
Onorato I la proposta di un vero e proprio protettorato con
reciproco scambio di concessioni: Carlo V assegnava al
signore di monaco il dominio su uno stato feudale composto
da diversi centri nel regno di Napoli, mentre il Grimaldi
cedeva alla Spagna la roccaforte monegasca. Terlizzi era
uno di quei centri e nel 1632 Onorato II Grimaldi vi fece
trasferire come arciprete-prelato il suo omonimo cugino,
fornendogli come abitazione proprio il castello, restaurato
per l'occasione.
Solo da un'attenta lettura di un dipinto anonimo risalente al
1600 ci si può fare un'idea di com'era il castello, non
essendoci pervenuta alcuna fonte grafica ma soltanto un
documento rinvenuto nell'Archivio di Stato di Napoli che al
foglio 167 contiene una nota descrittiva. Il castello nel
dipinto appare strutturato nelle sue componenti essenziali: il
maschio sull'ingresso con la sua bertesca e il cammino di
ronda, il nucleo abitativo, sui due lati le superstiti strutture
del recinto fortificato, in cui era compreso il torrione. Il
profilo architettonico della torre appare perfettamente
delineato in piena rispondenza ai canoni costruttivi del
tempo, come avamposto militare di difesa. Il primo livello
appare munito alla sua base di una scarpa di rinforzo, una
specie di piano inclinato rispetto alla verticale. Allo stato
reale il primo ripiano di base è posizionato nell'ipogeo, con
un proprio ingresso laterale, cui si accede attraverso dei
cunicoli. Il vano ipogeo si presenta necessariamente meno
capiente di quello a livello stradale proprio per la maggiore
ampiezza delle murature di base, ma ripete gli stessi motivi
architettonici del vano del livello superiore, con l'apertura,
cioè, in chiave di volta per i collegamenti verticali e il
paramento murario in pietra faccia a vista.
Fatta eccezione degli interventi di ristrutturazione e restauro
prima menzionati non si hanno altri riscontri di impiego di
opere edilizie. Solo quando la pubblica amministrazione,
con il riscatto feudale del 1779, rientrò in possesso delle
proprietà del demanio comunale, potette correre ai ripari
recuperando nei primi decenni dell'ottocento alcuni locali
che adibì a usi diversi. Purtroppo continuarono a verificarsi
crolli di membrature superstiti fino a quando non divennero
comode cave di materiale edilizio per portare a compimento
la costruzione della nuova cattedrale. Intorno agli anni
sessanta dell'Ottocento scomparve ogni altra traccia del
castello.
Oggi rimane la sola torre maggiore che si erge come torre
civica e simbolo della città.
Nel già citato dipinto essa appare, per ragioni di prospettiva,
marginale e di ridotte dimensioni ma comunque
caratterizzata come le comuni torri di difesa del periodo.
Appare quindi merlata alla guelfa, munita cioè di parapetto
con merli piatti e non a coda di rondine (alla ghibellina) e
collegata con il cosiddetto arcus pinctus (arco dipinto).
I primi lavori per adibire la torre normanna a servizio della
comunità ebbero inizio negli anni venti dell'Ottocento.
Insieme ai suoi connotati originali essa aveva perso
l'aspetto severo della sua primitiva funzione, e nella nuova
veste appariva ancora possente e maestosa, assurta a
emblema civico e prestata al servizio e utilità dei cittadini
con l'installazione di un orologio a pendolo da torre. Il
decurionato promosse e accolse il progetto del nuovo
pubblico orologio a firma dell'architetto Giovanni Lospoto
(Terlizzi, 1792-1855). Esigenze tecniche e prospettiche
contemplate nel progetto, per le eccezionali dimensioni del
nuovo organismo meccanico, richiesero la sopraelevazione
della grande mole della torre di alcuni metri, a partire dal
ripiano merlato, per situarvi l'ampio quadrante.
Complementare e insostituibile fu la costruzione dell'edicola
campanaria, naturalmente dotata di una robusta
incastellatura di supporto a due campane, elevandosi per
oltre dieci metri sul livello terminale della torre. La parte
terminale è costituita da una classica cuspide piramidale,
che si staglia sui tetti delle case a casba del borgo antico.
Dapprima ricoperta da lastre protettive di piombo (1820-
1842) venne poi rivestita di maioliche gialle e blu, mentre
alcuni segni zodiacali sono incisi su tre delle fasce frontali
degli architravi di base della stessa cuspide, sorretti da
quattro poderose colonne neoclassiche poggianti a loro
volta su basamenti di plinti quadrangolari.
A pianta quadrata, la torre si eleva su massicce fondamenta
per cinque livelli e altrettanti ambienti, con salde mura
perimetrali in pietra calcarea. Le volte si presentano a
diversa tipologia architettonica: a padiglione, la volta
dell'attuale piano a terra, e a botte tutte le altre dei quattro
livelli.
L’altezza della torre risulta rilevata per la prima volta dal
sindaco dell’epoca, al termine dei lavori di trasformazione
per installare il pubblico orologio (1822-25), per la misura di
palmi 100, in una sua relazione presentata in consiglio,
appunto sul progetto di ristrutturazione della “moderna
torre civica”. Nel calcolo moderno il palmo napoletano è
dato per cm 26 e qualche millimetro, per cui l’altezza della
torre, naturalmente dall’attuale livello stradale al lastrico
solare, veniva a corrispondere a metri 26. Una successiva
relazione tecnica la riporta nella misura di palmi 120,
riferendosi certamente all’altezza complessiva della torre e
dell’edicola campanaria. Si tratta pur sempre di misure
approssimative. Grazie ad alcuni studi1 si è riusciti a
determinare quanto segue:
· l’altezza complessiva della torre con edicola campanaria,
dal livello stradale all’apice della croce è di m.37,839;
· l’altezza della sola torre, dal livello stradale al lastrico
solare, è di m.26,339;
· l’altezza dell’edicola campanaria con la cuspide
piramidale, dal lastrico solare all’apice della croce, è di
m.11,50;
· l’altezza della sola edicola campanaria, senza la cuspide
piramidale è di m.6,00;
· l’altezza della sola cuspide piramidale, dall’architrave di
base, è di m.3,50;
· l’altezza dell’asta con globo, banderuola e croce è di
m.2,00;
· la larghezza della torre, a livello del suolo, è di m.9,04.
Una caratteristica molto importante della torre è costituita
dall’ampio quadrante del pubblico orologio, annoverato dagli
esperti tra i più grandi d’Europa. Il suo diametro, compresa
la grande cornice in pietra, misura complessivamente
m.4,30, mentre il diametro del solo quadrante è di m.3,45.
Misure della torre rilevate al raggio laser.
Nel corso del tempo, con il processo di riuso e
rifabbricazione, degli ambienti sorti sulle rovine del castello,
la torre è stata lentamente assorbita, inglobata per tre lati e
per circa metà altezza nelle maglie del tessuto urbano.
Mentre i tre prospetti laterali ne hanno conservato intatta,
per la maggior parte, la tessitura originale, quello frontale
prospiciente il borgo è stato sottoposto nel tempo a
trattamenti diversi. Tra l’altro, a completamento dei lavori di
sistemazione dell’orologio, nel 1822, per metterlo in vista,
l’intera superficie del paramento murario della facciata
venne fatta ricoprire da intonaco civile e mascherare con
listellature a falsi blocchi di pietra. Venne però liberata e
ripulita del vecchio intonaco e fatta sottoporre a una difficile
operazione di “stilatura” dei conci, in occasione degli
interventi di restauro del 1972.
1 Studi compiuti grazie alla collaborazione dell’arch. Paola Chiara Vino.
Notevole interesse storico e culturale rivestono gli ipogei, i
sotterranei della torre e del castello. Non si tratta di
semplici e normali cantine dalla comune tipologia, ma di
gallerie e cunicoli di complemento alle antiche strutture
fortificate di superficie e in funzione di opere di difesa e di
vie di fuga, anche per la stessa popolazione, forniti come
sono di cisterne d’acqua profonde fino a 35 metri e tuttora
efficienti.
Molto interessanti per la loro particolare incidenza, storica e
culturale, sono le lapidi e gli emblemi araldici affissi alla
torre, in particolare la lapide della libertà e gli scudi araldici
della città e del Regno delle Due Sicilie. Essi furono fatti
incastonare sulla facciata della torre in occasione della
celebrazione della conclamata libertà dal giogo feudale
concessa da Ferdinando IV il 10 luglio 1770. Dei sentimenti
di gratitudine espressi dalla cittadinanza per la libertà
conseguita dalla regia liberalità e clemenza, si rese
interprete il sindaco di quell’anno Ferrante de Gemmis
Maddalena, notissimo in Terra di Bari come riformista e
letterato, dettando una solenne epigrafe2. Doveva tuttavia il
dettato dell’epigrafe commemorativa rivelarsi a distanza di
qualche anno un’autentica beffa, mentre resta ancora lì,
quella lapide, sulla facciata della torre, a fare bella mostra
di sé, quale esemplare falso storico, traducendosi in realtà
in un monumento perenne all’amara delusione del popolo
terlizzese, che si vide beffato dalla “graziosa liberalità” del
sovrano. Dopo nove anni, infatti, il re mise nuovamente in
vendita la città al migliore offerente, ma fu Terlizzi ad
aggiudicarsi l’asta pubblica (1779), riscattandosi al prezzo di
centomila ducati.
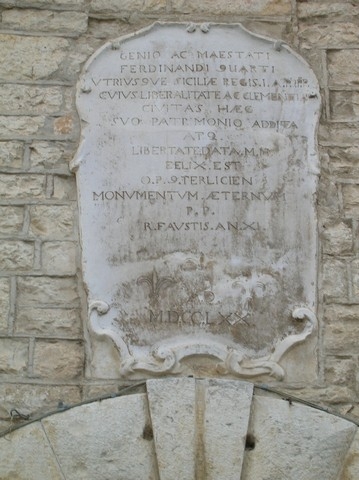 Torre maggiore. La lapide della liberta'.
Per onorare il re Ferdinando IV Borbone per la sua
liberalità, il sindaco Ferrante de Gemmis fece incastonare
sulla facciata della torre, ai due lati della lapide, oltre allo
stemma lapideo della città di Terlizzi, anche quello del
regno delle Due Sicilie (Napoli e Sicilia), quest’ultimo
raffigurato con gli antichi emblemi araldici della Trinacria e
di un Cavallo rampante. Trinacria (tre punte) è il nome
greco della Sicilia, a indicare i tre capi dell’isola siciliana
(Pachino, Lilibeo, Peloro). I Romani la chiamarono Triquetra
e furono loro a raffigurarla con l’attuale emblema
consistente in tre gambe unite intorno a un centro, formato
da un volto umano, e che sembrano roteare una dietro
l’altra inseguendosi. Lo scudo, a sua volta, è caricato in
cima dai tre gigli d’oro di casa Borbone.
Torre maggiore. Scudo araldico del regno delle Due
Sicilie.
Lo stemma della città di Terlizzi, raffigurato nella dura
pietra locale, sotto forma di scudo con torre merlata, in
campo pieno, sovrastata da altre tre torri, ugualmente
merlate e caricate in cima da figure araldiche, la maggiore
e centrale dall’effigie alata e guerriera del patrono della
città, l’Arcangelo San Michele, quelle laterali e minori da
due simboli chiaramente ispirati alla mitologia classica, sulla
destra la civetta, sacra alla dea Minerva e sulla sinistra il
gallo, sacro a Marte, Apollo e Mercurio, a significare,
secondo una tradizione di cultura locale, il carattere sveglio
e attento degli abitanti e, soprattutto, il culto dagli stessi
praticato, pagano prima e cristiano poi, insistendo la stessa
tradizione campanilistica nel voler indicare l’antica origine
greca della città.
Torre maggiore. Scudo araldico di Terlizzi.
La torre è rimasta, fino a qualche anno addietro,
impenetrabile a causa del divieto d’accesso sia per la
presenza dei delicati meccanismi dell’orologio da torre a
pendolo, sia per l’estrema precarietà dei collegamenti dei
vari livelli. L’amministrazione pubblica negli anni 1997-99 ha
operato il recupero totale e la piena fruizione della torre
mediante l’utilizzo delle risorse dei Programmi Operativi per
la Puglia (POP-II triennio 1997-99). I progetti esecutivi
hanno avuto anche lo scopo di rendere agevole la
percorribilità verticale della torre e consentire quindi la
totale fruibilità ai turisti.
Tratto da: G. Valente, La torre maggiore del castello
normanno in Terlizzi, Quaderni della Biblioteca n.7, De
Biase, Ruvo di Puglia, 2005, pp. 9-53.
2 Cfr. G. Valente, La 7torre maggiore del castello normanno in Terlizzi,
Quaderni della Biblioteca n.7, De Biase, Ruvo di Puglia, 2005, pp.66-6.
Torre maggiore. Marmo commemorativo.
Torre maggiore. Marmo commemorativo.
Torre maggiore. Edicola campanaria.
|

