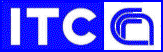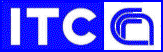|
Bitonto. Porta Lamaja – ingresso al centro storico.
Sito n.: 60 - PORTA DEL CARMINE
Morfologia e trasformazioni delle mura urbiche di
Bitonto. Alcune note
Il “restauro” seicentesco di Porta Maja
Nella struttura formativa delle mura urbane bitontine le
modificazioni effettuate nel secondo Seicento sull’antica
Porta Maja costituiscono una sorta di pietra miliare. La
porta era costituita da un impianto piuttosto semplice: un
ambiente voltato a botte acuta, che rendeva visibile
l’archivolto all’esterno come oggi appare dall’interno del
perimetro murario.
Bitonto. Porta e Torrione Lamaja.
Nel XVII secolo il fornice, collocato tra una torre
quadrilatera normanna ed una circolare angioina (ancora
oggi ampiamente visibili), era servito da uno spazio
antistante che confluiva su un terrapieno. Quest’ultimo
attraversava la Lama e varcava un ponticello ad arco acuto
posto nei pressi del complesso conventuale dei Padri
Carmelitani (attuale Istituto Maria Cristina di Savoia). Il
profilo di Porta Maja appariva ad un livello superiore
rispetto a quello oggi visibile, poiché l’anzidetto terrapieno
insisteva ad un livello inferiore a quello attuale. Nell’anno
1677 la struttura medievale del fornice viene integrata con
un impaginato esterno. Si tratta di un robusto e plastico
paramento in forme attualizzate, costituito da un nuovo
fornice con archivolto ad elementi bugnati cui vengono
associate semicolonne binate su plinto, con capitelli,
architrave e timpano. La cornice sull’arco unifica la
composizione generale e fa da base, oggi, allo stemma
lapideo dei Savoia e alla sovrapposta statua, pure lapidea,
della Madonna del Carmelo con Bambino.
L’inserimento del nuovo arco semicircolare avviene anche
ricalibrando la collocazione del fornice. La posizione del
vecchio arco, infatti, collineare rispetto alla torre normanna,
ma arretrata rispetto alla mole angioina, faceva apparire il
piedritto sinistro pressoché strozzato dal corpo di
quest’ultima. L’impaginato seicentesco riduce l’area del
vano di ingresso, abbassandolo ed allontanandolo dalla
torre cilindrica quel tanto che basta per potervi inserire il
piedritto a semicolonne binate. Il timpano sinistro, mozzato
sul paramento della torre angioina, è l’effetto di tale sforzo
compositivo. La nuova porta acquisisce equilibrio, dunque,
in una rinnovata struttura formale, basata non soltanto
sull’introduzione di elementi di architettura corrente, ma
anche sulla collocazione del fornice ricalibrata sull’assial-
simmetria del nuovo impaginato.
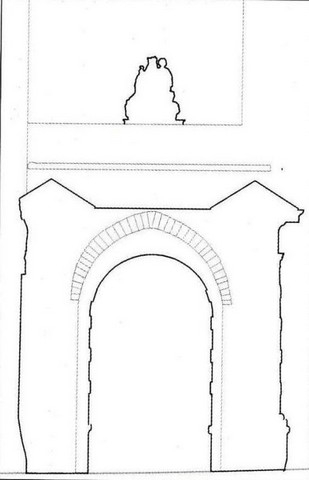
Porta del Carmine. Prospetto anteriore.
Ricostruzione del profilo della struttura medievale
(grigio) e collocazione della sovrastruttura barocca
oggi visibile (nero).
Un intervento pregevole, che ha dato nuova forma e dignità
alla Porta. È, infatti, appena il caso di ricordare che nella
ingegneria delle fortificazioni le porte costituivano sì
l’ingresso all’insediamento, ma anche un elemento
vulnerabile, formando una breccia nella struttura munita. La
qualità del nuovo impaginato seicentesco toglie a Porta
Maja questa caratteristica di ‘male necessario’, facendola
diventare un evento architettonico di rilievo: essa deve
potentemente rappresentare, oltre che essere, l’ingresso
alla città. Cosicché ‘Porta del Carmine’ proiettava
all’esterno, sul versante meridionale, il primo, significativo
messaggio dell’istanza di lustro, decoro e cultura della
comunità presente entro quel perimetro. Il rinnovamento
della sua forma si inserisce peraltro in una lunga stagione
di costruzione di residenze nobiliari (secoli XVI-XVIII), i cui
portali contengono parecchi caratteri accomunabili a quelli
di Porta del Carmine (in alcuni casi anche enfatizzati in
essa).
Questa condivisione rende l’ingresso alla città come
l’accesso ad una grande residenza collettiva.
Porta del Carmine (Bitonto). Sezione longitudinale e
prospetto anteriore.
Sezione longitudinale della Porta del Carmine
(Bitonto).
Porta del Carmine. Pianta.
Con la nuova immagine le mura bitontine non sono più solo
struttura difensiva ma anche architettura intenzionalmente
rappresentativa di una comunità.
Il “restauro” seicentesco di Porta Maja consiste in una
modificazione con cui l’ingresso alla città assume nuova
veste ed attualità estetica. Detta modificazione si
concretizza in una integrazione esclusivamente corticale
esterna. L’analisi degli aspetti costruttivi restituisce ulteriori
dati sulle caratteristiche dell’intervento. Al paramento
anteriore della porta medievale viene agganciata una
sovrastruttura che copre fornice e piedritti con elementi
lapidei stereotomicamente lavorati: semicolonne binate,
montate su plinti parallelepipedi, basi toriche, capitelli
tuscanici, trabeazione con timpano su ogni coppia di
colonne. La potenza, le caratteristiche del taglio e della
lavorazione superficiale delle parti conferiscono alla
struttura un notevole effetto plastico ed uno sviluppo
verticale degli elementi architettonici aritmicamente
scandito dalla vigorosa esaltazione delle fasce orizzontali.
Diversi aspetti concorrono a siffatta caratterizzazione
architettonica. I fusti delle colonne, ad esempio, sono
formati da semirocchi di alternata profondità, cadenzata per
piani orizzontali, che si rendono continui con gli elementi del
paramento e dell’archivolto. I pezzi uscenti, inoltre, sono
compressi rispetto a quelli rientranti. I primi assicurano così
la percezione della robustezza. I secondi, più alti, il senso
della snellezza, al cui effetto si relaziona pure la
progressiva rastremazione verso l’alto degli elementi. Alla
esaltazione del contrasto plastico tra elementi si relaziona il
trattamento della superficie lapidea, che alterna piani
scabri, con spigolo vivo o stondato, ad altri appena ruvidi.
Il sistema di aggancio della nuova struttura alla esistente
risulta essere conformato con ammorsature a sviluppo
orizzontale, senza particolare profondità di ingranamento,
come era più o meno in uso proprio nelle chiese di età
barocca per i sistemi di collegamento tra facciate e
retrostruttura portante. Questo, naturalmente, evidenzia
che il fornice medievale deve aver subito consistenti tagli,
benché non troppo profondi, per farvi aderire la
sovrastruttura barocca.
Gli elementi di colonna sono tagliati a forma semicircolare
con ispessimento interno lineare, funzione del serraggio
nella sede muraria. In alcuni filari il pezzo, circolare (di
colonna) quello parallelepipedo (di paramento) sono divisi
dai relativi giunti. In altri filari detti elementi costituiscono
un pezzo unico sagomato, che si sviluppa per tutta la
corrispondente semifascia orizzontale. Tale assito dei
blocchi risulta variamente alternato, rispondendo ad una
ricercata tessitura paramentale che assicura autonoma
stabilità al nuovo impaginato.
Le caratteristiche costruttive della sovrastruttura
seicentesca sono dunque funzione della conformazione di
una nuova, potente e pressocché autoportante “epidermide”
sul testo medievale.
estratto dell’articolo pubblicato sulla rivista semestrale
“Studi Bitontini” 80, 2005, 21-40 di Tommaso Maria
MASSARELLI.
Bitonto. Cardine sinistro di Porta Lamaja.
Bitonto. Cardine destro di Porta Lamaja.
|