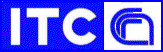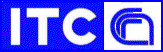|
Sito n.: 1 - CASTELLO NORMANNO SVEVO
Il castello di Sannicandro sorge nella zona medievale del
paese, tra le caratteristiche case a scalinata esterna,
isolato dalle costruzioni circostanti, circondato da una
strada che, almeno in parte, dovrebbe insistere sull’antico
fossato colmato solo nel 18361.
Il castello “ha in pianta la forma complessiva di un
quadrilatero con uno degli angoli alquanto smussato2” che
occupa una superficie di circa 2850 mq, palesemente
costituita da un insieme di successive stratificazioni che nel
corso dei secoli ne hanno progressivamente mutato
l’aspetto.
Possiamo individuare, dal punto di vista dell’evoluzione
architettonica, due categorie distinte:
1. insieme di tutte le strutture caratterizzate da
un’evoluzione organica del complesso architettonico, che da
semplice struttura di difesa militare, diviene sede di un
feudatario; evoluzione che si prolunga per secoli,
seguendo, presumibilmente, le vicende storiche del feudo
stesso;
2. insieme delle opere realizzate in un arco di tempo molto
ristretto per soddisfare esigenze, di carattere economico,
da parte del Capitolo, in quel periodo proprietario della
struttura; si tratta di lavori eseguiti principalmente tra il
1772 ed il 18743, che comportarono una grave alterazione
dei caratteri tipologici, architettonici e costruttivi fino a
renderlo quasi irriconoscibile.
Attualmente, osservando il castello dall’alto sono evidenti
due successive costruzioni anulari concentriche e un
insieme di altri volumi che, con il passare dei secoli, sono
andati ad addossarsi alle due cortine murarie, o, in alcuni
casi, a sostituirsi del tutto ad esse.
Figura 1 - foto storica aerea
La cortina interna si presenta più integra di quella esterna,
in quanto quest’ultima ha subito numerosi rifacimenti ed
integrazioni dovuti specialmente all’apertura in breccia di
nuove porte.
In una prima fase, doveva però costituire la cinta di
confine, come è dimostrato dallo spessore, eccessivo per
dei muri divisori, dal portale che si apre sul lato est e dalle
saettiere a bocca di lupo4.
E’ possibile individuare le seguenti fasi costruttive, le prime
tre specifiche del castello, mentre la quarta si riferisce
all’impropria utilizzazione del complesso quando entrò a far
parte dei possedimenti della Basilica di S. Nicola5:
1° fase: semplice recinto quadrangolare, costituito da
muratura di pietrame sbozzato, non dotato di torri, ma con
gli angoli arrotondati;
2° fase: castello costituito da murature perimetrali
realizzate su quelle del recinto di prima fase, torri negli
angoli ed al centro dei lati;
3° fase: ampliamento del castello, con la realizzazione di
una cinta più esterna e di grandi ambienti di
rappresentanza e di due nuove torri sul lato nord e la
trasformazione da luogo di difesa a dimora di feudatario;
4° fase: ristrutturazione del castello per un suo più intenso
sfruttamento economico, conseguito specialmente con la
realizzazione delle opere ottocentesche 6.
Figura 2 - fasi evolutive
L’esistenza del recinto di prima fase è stata avvalorata dai
lavori di restauro7, i quali hanno riportato alla luce un
recinto murario costruito in conci irregolari di pietra
calcarea, con gli angoli arrotondati, in cui è presente anche
il probabile portone di accesso, nonché diverse murature
ad esso connesse8.
Figura 3 - resti recinto murario ala nord
Figura 4 - torre sud-ovest
La datazione della cortina, presumibilmente intorno al X
sec., rinviene dallo studio del materiale ceramico ritrovato
in un condotto fognario, realizzato in corrispondenza della
porta, e dalle monete raccolte nei pressi delle fondazioni
dei muri connessi al recinto.
Questo ritrovamento potrebbe avvalorare la tesi dello
Scalera9, il quale parlava di un fortilizio bizantino.
L’antico muro in pietrame, situato sotto l’attuale piano di
campagna, fu sopraelevato da un altro muro di bolognini di
pietra squadrata, con torri negli angoli e al centro dei lati
est ed ovest; sia nel muro di cinta che nelle torri sono
aperte feritoie e merlature.
Le torri, che delimitano la cortina, non sono innestate alla
muratura, ma semplicemente aderenti alla stessa: questa
caratteristica dice chiaramente che la cortina muraria è
stata ricostruita in un periodo successivo.
Non si conosce l’originario numero delle torri, delle quali sei
sono giunte fino a noi, ma si presume che anche la cortina
nord e quella esposta a sud fossero munite di torri centrali.
L’ipotesi si basa sull’osservazione, nella parte centrale della
cortina nord relativa alla seconda fase, di un’apertura,
coeva alla stessa muratura, la cui base è posta ad una
quota più bassa (120 cm) di quella originaria del locale di
primo piano10.
Si è cercata un’ ulteriore conferma, eseguendo alcuni saggi
in fondazione, che però non hanno fornito nessun elemento
aggiuntivo, in quanto tutto il lato nord presenta al piano
seminterrato un grande locale, con il piano di calpestio
immediatamente al di sopra del piano roccioso. L’unico
elemento che rafforza questa ipotesi è la presenza, nel
rinfianco della volta di copertura, di alcuni conci che
potrebbero essere i resti dell’ammorsatura dei muri della
torre scomparsa.
Probabilmente, in un primo momento, non c’erano corpi di
fabbrica realizzati in aderenza al muro di cinta; infatti, lo
studio delle murature ha permesso di collocare, la
realizzazione degli stessi, in tempi successivi. Questi volumi
erano coperti da orizzontamenti lignei11, dei quali restano,
a testimonianza, solo i fori di appoggio delle travature,
nascoste nei rinfianchi delle volte in tufo12.
L’unica eccezione è costituita da un piccolo ambiente
situato nell’angolo nord – ovest, suddiviso in un piano terra,
un primo piano e il terrazzamento che permette l’accesso
allo stesso.
Figura 5 - esterno della chiesa
Il piano terra, senza accesso dall’esterno, si compone di
due vani, di cui uno caratterizzato da due archi ogivali con
bassa quota del piano di imposta, come per quello al primo
piano.
Figura 6 - piano terra ambiente chiesa
Figura 7 - primo piano chiesa
Le strutture circostanti appartengono ad un periodo
successivo, e per accedervi si utilizza un terrazzamento
posto ad un’altezza superiore rispetto a quella del suddetto
ambiente. Sembra quasi che nella fase di ampliamento i
lavori siano stati effettuati cercando di salvaguardare
l’integrità di questo ambiente d’angolo, quasi si trattasse di
un ambiente sacro.
In effetti, in alcuni documenti risalenti al periodo normanno
e svevo13 si fa riferimento ad una chiesa, dedicata a S.
Nicola, posta all’interno del “castrum Sancti Nicandri”.
Figura 8 - scala e pianerottolo accesso chiesa
L’ipotesi che questo ambiente sia proprio la suddetta chiesa
è stata avvalorata dagli scavi precedenti al restauro: infatti,
lo svuotamento del materiale che lo riempiva interamente
fino alla quota di primo piano, ha portato alla luce alcuni
ricorsi di conci nei quali si è individuato un abside, mentre
la stonacatura delle pareti ha evidenziato su di un arco i
resti di un affresco raffigurante due volti umani.
Figura 9 - visione dal basso della copertura della
chiesa
Figura 10 - particolare resti affresco
Nella fase successiva, caratterizzata da una organica
evoluzione del recinto piuttosto che da un unico momento
costruttivo, la struttura esistente ha subito una serie di
modifiche ed ampliamenti:
a. realizzazione di una nuova cortina muraria concentrica a
quella esistente;
b. ampliamento del corpo di fabbrica connesso con la
cortina nord, prospiciente la corte interna;
c. realizzazione di un grande corpo di fabbrica, destinato a
contenere le sale di rappresentanza, idonee alla dimora di
un feudatario, compreso tra due nuove torri;
d. ristrutturazione delle due torri appartenenti alla cortina
ovest del vecchio recinto.
Cronologicamente, il primo intervento ha riguardato i due
saloni al piano terra, posti all’interno del recinto di seconda
fase. Per accedere a questi ambienti si utilizzava una
scalinata14, che portava ad un terrazzamento ricavato sul
primo piano di un ulteriore corpo di fabbrica, anch’esso di
recente fattura.
Allo stesso periodo dovrebbe risalire la foderatura esterna
del lato est con un nuovo paramento murario15 e il portale
di accesso sul lato nord.
Come possiamo vedere dalle immagini, i due portali
presentano lo stesso architrave eccentrico a sesto rialzato
composto di conci radiali in rilievo che fanno corona ad un
sottoarco piano eccentrico. L’unica differenza tra i due
portali consiste nel trattamento dei conci: mentre quelli del
portale esterno sono lavorati a bauletto, quelli del portale
interno sono a faccia piena.
Figura 11 - portale lato nord e portale accesso corte
interna
Le conoscenze attuali non permettono di formulare una
data precisa per questa fase, né tantomeno di valutare
l’estensione del recinto appartenente alla stessa.
L’ultima modifica fu la realizzazione, nella parte nord, di un
corpo di fabbrica, interposto tra due nuove torri.
Possiamo individuare tre livelli:
1. piano seminterrato, con il piano di calpestio a 3,6 metri
sotto il piano di campagna; l’ambiente è ricoperto da una
volte a botte a sesto ribassato, destinato probabilmente a
deposito o cantina16;
2. piano rialzato, inizialmente utilizzato come stalla, ma
successivamente come ambiente di rappresentanza e per
spettacoli teatrali; la soluzione strutturale utilizzata consiste
in un solaio ligneo poggiante su arcate trasversali in pietra;
3. primo piano, non si presenta come un ambiente unico,
ma suddiviso in tre grandi sale17, ciascuna illuminata da
una bifora. Per realizzare la copertura, costituita da una
grande volta a botte ogivale, in conci di pietra a corsi
regolari, fu necessario rinforzare uno dei muri di imposta
della stessa, con un sistema di archi di scarico. Il salone
esposto ad est presenta i resti di un altare incassato nella
muratura con tracce di antichi affreschi.
Figura 12 - salone piano rialzato nord
Figura 13 - salone primo piano nord svevo
Figura 14 - particolare archi di scarico
Figura 15 - particolare affresco
La costruzione precedente, con le nuove torri, determinò
uno spazio angusto tra le due torri di nord – est, vecchia e
nuova: molto probabilmente, proprio per migliorare la
situazione, fu edificata una parete che ha conferito alla
vecchia torre una pianta pentagonale. I lavori di restauro
hanno dato conferma a questa ipotesi, dimostrando che in
origine si trattava di torre a pianta quadrata18.
Abbiamo parlato di una terza fase dilatata nel tempo;
volendola collocare cronologicamente, dobbiamo fare delle
ipotesi basandoci sull’analisi stilistica del monumento e
sullo studio dei documenti a disposizione.
La soluzione del solaio in legno poggiante su archi in pietra
la ritroviamo in altri castelli di epoca federiciana, come il
castello di Bari e quello di Trani: tuttavia, l’ipotesi di una
ristrutturazione federiciana non ha trovato riscontro nei
documenti storici, che dimostrano l’appartenenza del
castello, nel XIII sec., al Vescovo di Bari.
D’altra parte, dal 1307 e fino al secolo scorso, con un vuoto
che va dal 1350 al 1415, il castello rientrava nei
possedimenti dei monaci della Basilica di S. Nicola, i quali
non avevano interesse a costruire imponenti saloni.
Alla luce di questo potrebbe prendere corpo l’ipotesi
dell’ampliamento e del rifacimento effettuati nel periodo
1350-1415, ad opera della famiglia Grimaldi, il cui stemma
è apposto al di sopra del portale est della cortina esterna.
Figura 16 - stemma Grimaldi
L’analisi ravvicinata dello stemma e della muratura che lo
contiene non ha fornito la prova
decisiva relativa alla contemporaneità di esecuzione tra lo
stesso e l’intervento di foderatura della parete19.
La quarta fase dell’evoluzione del castello ha inizio,
considerando i documenti storici, con l’atto di donazione
dello stesso e di metà del castello di Rutigliano, da parte di
Carlo II d’Angiò al Capitolo di S. Nicola. Nell’atto, risalente
al 1304, si parla di una concessione “in feudum
nobilem…”20 in cambio di una rendita annua di 200 once
d’oro.
In questa nuova condizione vengono meno le esigenze
militari, in base alle quali il castello si era andato formando,
e si delinea una nuova fase nella quale il monumento
diviene il centro direzionale della vasta azienda agricola
feudale.
Dai documenti rintracciati nell’archivio di San Nicola,
veniamo a conoscenza di una serie di interventi costruttivi
che modificarono brutalmente la fisionomia del castello. Il
primo intervento risale all’incirca alla fine del XV sec.21, e
riguarda la realizzazione di un mulino nella parte
meridionale della corte esterna22.
Sempre funzionale all’azienda agricola, nel 1588 fu
installato un “centimolo”23 nei vani a pianterreno che si
affacciano sul cortile interno24.
Da un documento redatto nel 1867 è possibile ricostruire la
pianta delle destinazioni dei vari ambienti di cui era
costituito il castello; il documento è “un inventario di tutte le
porte, finestre e serrature fatte nuovamente nel castello di
S. Nicandro Terra Real Capitolo di S. Nicolò" 25.
Esaminando il documento si può osservare che la struttura
era costituita da poche “cammere” e da molti ambienti
funzionali all’attività agricola. E’ probabile, però, che
dall’elenco siano esclusi i saloni del primo piano nord,
destinati alla dimora del feudatario.
Da un altro, datato al 1772, si ricavano una serie di lavori
realizzati da Nicola Domenico Colella26: non è indicata
l’esatta ubicazione delle “ nuove fabbriche”, ma
presumibilmente interessavano il primo piano nella parte
ovest e nord. Tra i lavori si parla della costruzione di una
scala27, che dovrebbe corrispondere a quella esistente
attualmente nel cortile interno.
Figura 17 - corte interna
Oltre a questi lavori, come abbiamo già detto, funzionali
all’economia, fu realizzato, per motivi igienici, il
riempimento del fossato28, che circondava il castello.
Questo fosso, inizialmente scoperto, era stato ricoperto da
una volta nella quale erano praticate delle aperture, per
l’estrazione periodica delle acque che venivano convogliate
in esso da appositi canali di scolo. La stagnazione di queste
acque reflue aveva creato, nella zona limitrofa, un
ambiente malsano e putrido, causa di malattie infettive. Nel
marzo 1816 fu presentato, all’Intendenza Provinciale, un
progetto che consisteva nel riempimento del fossato e nella
sostituzione, della volta dello stesso, con un nuovo piano
stradale29.
Nel 1850 il castello fu colpito da un gravissimo incendio che
distrusse tutte le decorazioni interne e rovinò volte e muri30.
Nel 1863 fu realizzato il portale esterno del lato est, come
indica il concio di chiave su cui è incisa la data, sormontata
da un bassorilievo raffigurante S. Nicola.
Figura 18 - stemma di S. Nicola sul portale est
Tra il 1863 e il 1875 furono eseguiti i lavori di
ristrutturazione del castello, che interessarono soprattutto
lo spazio compreso tra le due cortine murarie: tale
operazione comportò il tompagnamento del portale nord ed
il parziale occultamento del portale d’accesso alla corte
interna.
Figura 19 - portale accesso corte interna
Furono aperte in breccia una notevole quantità di porte e
finestre, per consentire l’illuminazione dei nuovi ambienti,
creati innalzando tramezzi e le bifore, presenti sul lato
nord, furono trasformate in porte-finestre con annesso
balcone.
Figura 20 - visione lato nord-est
Figura 21 - visione lato est
Figura 22 - prospetto nord
Le otto sezioni del solaio in legno del piano rialzato di
settentrione furono sostituite con otto volte a crociera in
tufo.
Figura 23: salone piano rialzato, lato nord
Tutte le modifiche ottocentesche furono effettuate col fine
di creare locali da affittare per un tornaconto economico31.
Alla base non c’era nessun progetto omogeneo e ordinato,
rispettoso del valore storico ed artistico della struttura.
L’indifferenza, da parte del Capitolo, verso l’importanza del
castello come esempio di architettura medioevale, lo ha
però tenuto lontano dai restauri in stile, molto diffusi in
quegli anni32.
L’azione di tutela dei monumenti, da parte del Governo33,
cominciò nel 1876, quando si erano già conclusi i lavori di
ristrutturazione.
Era interesse del Capitolo non far includere il castello fra i
monumenti nazionali: infatti, allo scopo, fu inviata, al
prefetto della Provincia, una relazione sullo stato
dell’immobile da parte dell’ingegnere capitolare Lionardo
Maurantonio34.
Nella relazione si parla di una sola torre “di costruzione
barocca”, affermazione del tutto falsa. Infatti all’epoca
erano già presenti sette torri e non di stile barocco.
Il Capitolo, grazie alla precedente relazione, raggiunse il
suo scopo: il castello non fu inserito nel suddetto elenco e
comparve una sola volta nei rapporti semestrali sui
monumenti archeologici.
Solo dopo il 1967, quando il castello fu acquistato dal
Comune, la situazione sembrò evolversi positivamente:
infatti, poco dopo la Sovrintendenza ai Beni Ambientali,
Artistici e Architettonici appaltava i primi lavori di restauro
finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno e curati dal prof.
De Tommasi.
1 N. Saliani, Sannicandro di Bari e il suo castello, Bari, 1996.
Dell’esistenza del fossato si deduce dal documento ASNB XXV-22-1768,
nel quale si parla del “ponte sud”. Il prof. Saliani afferma che, a seguito
degli scavi per la posa dei tubi di acquedotto e fognatura, sono stati
rinvenuti ampi tratti del muro di sostegno del fossato. Dello stesso si
parla anche in un carteggio tra l’Intendenza di Provincia ed
Amministrazione Comunale avvenuto negli anni 1817 e 1818, Archivio di
Stato, Intendenza-Amministrazione Comunale antica-Opere pubbliche,
busta 39, fasc. 481.
2 G. Bacile di Castiglione, Castelli Pugliesi, Roma 1927, p. 257.
3 La serie di lavori effettuati, in quegli anni, è documentata da una
serie di documenti, conservati nell’archivio della Basilica di San Nicola.
Confronta:
ASNB fasc. XXV n° 12 - anno 1772;
ASNB fasc. II n° 13 – Riparazioni effettuate nel 1827;
ASNB fasc. VI n° 54 – anno 1860/1863;
4 Tali feritoie si aprono, attualmente, nei locali addossati all’esterno
della vecchia cinta muraria.
5 G. De Tommasi, Il restauro del castello di Sannicandro di Bari,
estratto da Continuità, Rassegna Tecnica Pugliese, n. 2/3 anno 1984,
p. 24
6 Tra il 1450 e la metà del XIX sec. probabilmente il castello, persa ogni
importanza militare, per acquisire quella di centro commerciale della
città, dovette progressivamente subire modificazioni ed alterazioni, ma
limitate e concentrate in gran parte del lato sud. Solo dopo l’incendio
del 1850 che danneggiò gravemente il castello con il crollo della torre
nord-ovest fu attuato quel complesso di opere che portarono al
completo stravolgimento dei caratteri dell’ala nord.
7 I lavori di restauro sono cominciati nel 1978, con i finanziamenti della
Cassa per il Mezzogiorno, e la Direzione dei Lavori curata dall’ing. De
Tommasi.
8 G. B. De Tommasi, op. cit., p. 26. Il ritrovamento, al di sotto del muro
di spina dell’ala nord, rientra nella serie di scavi effettuati nell’angolo
nord – ovest, ed ha trovato conferma in un successivo ritrovamento,
nell’angolo sudovest, durante dei lavori di scavo effettuati dal Comune.
9 Scalera G., 1900, Notizie storiche sulla terra di Sannicandro di Bari
dalle sue origini fino all’epoca presente, Palo del Colle.
10 G. B. De Tommasi, op. cit., p. 29.
11 Il castello è stato vittima, nel 1850, di un incendio che lo ha
danneggiato gravemente. Probabilmente, è stato quest’ultimo la causa
della distruzione dei solai in legno.
12 G. B. De Tommasi, op. cit., p. 28.
13 Tansi, op. cit., pp. 47-79-160-161.
14 Probabilmente la scalinata originaria è stata distrutta e ricostruita in
un periodo successivo, ed è stata posizionata diversamente dalla prima.
15 G. B. De Tommasi, op. cit.
16 N. Saliani, op. cit.
17 I tre ambienti sono individuati da due tramezzi, dei quali
attualmente, solo uno è originario, mentre l’altro è stato ricostruito
durante i lavori di restauro sulla traccia dell’esistente. Confronta G.B.
De Tommasi, op. cit., 30-31.
18 Cfr. G. B. De Tommasi, op. cit., pp. 32-33.
19 Cfr. G. B. De Tommasi, op. cit., p. 29.
20 Codice Diplomatico Barese, vol. XIII, doc. 135, pp. 205- 206.
21 ASNB, Archivio Capitolare, fondo cartaceo, sez. “Sannicandro”,
doc. n. 230.
22 Il nuovo ambiente fu ottenuto realizzando un copertura a volta
nello spazio libero compreso tra le due cortine murarie concentriche. La
stessa maniera di operare fu utilizzata anche per altri ambienti, alcuni
dei quali, localizzati nell’angolo sud – est del castello, si sono conservati
fino ad oggi.
23 Frantoio.
24 ASNB, Archivio Capitolare, fondo cartaceo, sez. “Sannicandro”,
doc. n. 17.
25 ASNB, Archivio Capitolare, fondo cartaceo, sez. “Sannicandro”,
doc. n. 103.
26 ASNB, fasc. XXV, n. 12.
27 Questa scala ha forse sostituito un’altra, di fattura medievale,
collocata parallelamente al muro ovest, che dava accesso al salone
nord.
28 Cfr. ASNB XXV-22-1768 oppure Archivio di Stato, Intendenza-
Amministrazione Comunale antica-Opere pubbliche, busta 39, fasc. 481.
29 I lavori di riempimento si conclusero entro il 1838, visto che
risalgono a quest’anno le note di spesa contenute in un fascicolo
conservato nell’Archivio di Stato. Cfr. Archivio di Stato, Intendenza-
Amministrazione Comunale antica- Opere pubbliche, busta 39, fasc.
480/2.
30 N. Saliani, op. cit. e G. Scalera, op. cit.
31 Archivio di S. Nicola di Bari, fondo cartaceo, Archivio Capitolare,
sez. “Gestione ex feudi”, doc. n. 3
32 Confronta C.A. Willemsen, D. Odenthal, Puglia terra dei Normanni e
degli Svevi, Bari, 1959.
33 Il Ministero dell’Istruzione Pubblica del regno d’Italia inviava ai
prefetti delle varie province alcune circolari con l’elenco degli edifici dei
quali si valutava l’inserimento tra i monumenti nazionali; i prefetti
dovevano verificare l’avvenuta manutenzione e trasmettere rapporti
semestrali sullo stato di conservazione.
34 Archivio di Stato di Bari, Monumenti e scavi, busta n. 6, fasc. n.
143. “…L’assieme della massa dell’edifizio che determina la propria
fisionomia è tutta mutata di forma per differenti circostanze concorse
col progredire degli anni. Il pomerio(fossato) che lo cingeva fu distrutto
dalle differenti sistemazioni ed ordinamenti stradali eseguiti dal
Municipio per pubblica utilità ed igiene….Una sola torre giaceva di
costruzione barocca senza merli e cortina non presentando alcuna idea
archeologica….Tutto è trasformato, e lo assieme presenta un
aggregato di casipole disposte ed improntate sull’andamento delle
delimitazioni delle mura.”
|